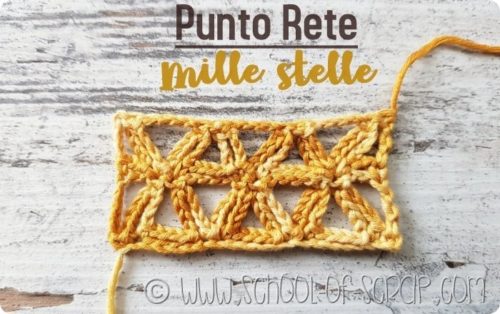Dulce bellum inexpertis
(Vegezio)
Il bellicismo come malattia senile del cretinismo cognitivo, perché la guerra piace a chi non l’ha mai provata.
![]() Ci sono autori che invecchiano malissimo e finiscono peggio. Prendete il caso (molto umano) di Antonio Scurati, uno che ha fatto dell’antifascismo (quello stereotipato e rassicurante, che tanto piace ai salottini finto progressisti degli intellettualini ‘liberali’) una professione a tempo pieno, peraltro ben remunerata (buon per lui!), finendo con l’infatuarsi dei bad characters da fumetto dei suoi romanzi, a tal punto da identificarsi con loro, non cogliendo più la differenza, ma assumendone le posture e financo il linguaggio.
Ci sono autori che invecchiano malissimo e finiscono peggio. Prendete il caso (molto umano) di Antonio Scurati, uno che ha fatto dell’antifascismo (quello stereotipato e rassicurante, che tanto piace ai salottini finto progressisti degli intellettualini ‘liberali’) una professione a tempo pieno, peraltro ben remunerata (buon per lui!), finendo con l’infatuarsi dei bad characters da fumetto dei suoi romanzi, a tal punto da identificarsi con loro, non cogliendo più la differenza, ma assumendone le posture e financo il linguaggio.
![]() L’Esegeta si era già prodotto in un’appassionata lirica apologetica, a celebrazione del Super Mario nazionale, il Dominatore, velocemente dispersa come scorreggia nel vento, lassù nelle “altezze olimpiche delle vette inarrivabili”,
L’Esegeta si era già prodotto in un’appassionata lirica apologetica, a celebrazione del Super Mario nazionale, il Dominatore, velocemente dispersa come scorreggia nel vento, lassù nelle “altezze olimpiche delle vette inarrivabili”, ![]() verso colui che “ha retto le sorti di una nazione e di un continente; le ha tenute in pugno con il piglio del dominatore, sorretto da una potente competenza, baciato dal successo, guadagnando una levatura internazionale, un prestigio globale, un posto di tutto rispetto nei libri di storia”, sbrodolandosi addosso con un’insuperata parodia dei Cinegiornali Luce, così parossistica che avrebbe messo in imbarazzo persino l’Agenzia Stefani.
verso colui che “ha retto le sorti di una nazione e di un continente; le ha tenute in pugno con il piglio del dominatore, sorretto da una potente competenza, baciato dal successo, guadagnando una levatura internazionale, un prestigio globale, un posto di tutto rispetto nei libri di storia”, sbrodolandosi addosso con un’insuperata parodia dei Cinegiornali Luce, così parossistica che avrebbe messo in imbarazzo persino l’Agenzia Stefani.
![]() A quanto pare, non si trattava di una febbre passeggera, perché il nostro eroe deve averci preso gusto, rivelando un inaspettato talento come panegirista di corte, col gusto per l’iperbole, senza essere mai sfiorato dall’ombra del ridicolo, mentre si masturba fantasticando di fantomatici “Guerrieri d’Europa”, in pieno orgasmo prebellico. È curioso come certi vecchi si eccitino al tintinnar di sciabole, reinventandosi strateghi e giocando alla guerra, che evidentemente deve funzionare per loro come il viagra, riscoprendosi diversamente giovani al rombo del cannone.
A quanto pare, non si trattava di una febbre passeggera, perché il nostro eroe deve averci preso gusto, rivelando un inaspettato talento come panegirista di corte, col gusto per l’iperbole, senza essere mai sfiorato dall’ombra del ridicolo, mentre si masturba fantasticando di fantomatici “Guerrieri d’Europa”, in pieno orgasmo prebellico. È curioso come certi vecchi si eccitino al tintinnar di sciabole, reinventandosi strateghi e giocando alla guerra, che evidentemente deve funzionare per loro come il viagra, riscoprendosi diversamente giovani al rombo del cannone.
![]() E il marziale Scurati è turgidissimo, intanto che leva i suoi ispirati proclami e lancia la chiamata generale alle armi dalla pagine del giornalone di Casa Elkann. Salvo che a combattere, il nostro eroe e quelli come lui ci vogliono mandare gli altri, muovendo i soldatini dal comodo divano di casa, concionando dietro biblioteche ricolme di libri che evidentemente non leggono. Non è solo. I cimiteri di guerra sono pieni di ventenni portati per mano alla morte, da cattivi maestri e garruli tromboni blasonati che attualmente infestano le redazioni dei giornali. Sono gli stessi imbonitori che non hanno mai visto un campo di battaglia ed a suo
E il marziale Scurati è turgidissimo, intanto che leva i suoi ispirati proclami e lancia la chiamata generale alle armi dalla pagine del giornalone di Casa Elkann. Salvo che a combattere, il nostro eroe e quelli come lui ci vogliono mandare gli altri, muovendo i soldatini dal comodo divano di casa, concionando dietro biblioteche ricolme di libri che evidentemente non leggono. Non è solo. I cimiteri di guerra sono pieni di ventenni portati per mano alla morte, da cattivi maestri e garruli tromboni blasonati che attualmente infestano le redazioni dei giornali. Sono gli stessi imbonitori che non hanno mai visto un campo di battaglia ed a suo ![]() tempo avrebbero venduto un rene, per avere l’esonero dal servizio di leva, come il pacioso e pasciuto Paolo Mieli che tra una portata e l’altra parla di sbattere la pistola sul tavolo e urla “combattiamo!”, forse credendosi Churchill (tutti eroi col culo degli altri!). Sono i nuovi professor Kantorek, in via di arrapamento per la Terza Guerra Mondiale:
tempo avrebbero venduto un rene, per avere l’esonero dal servizio di leva, come il pacioso e pasciuto Paolo Mieli che tra una portata e l’altra parla di sbattere la pistola sul tavolo e urla “combattiamo!”, forse credendosi Churchill (tutti eroi col culo degli altri!). Sono i nuovi professor Kantorek, in via di arrapamento per la Terza Guerra Mondiale:
«Kantorek era il nostro professore: un ometto severo, vestito di grigio, con un muso da topo.
[…] Nelle ore di ginnastica Kantorek ci tenne tanti e tanti discorsi, finché finimmo col recarci sotto la sua guida, tutta la classe indrappellata, al Comando di presidio, ad arruolarci come volontari. Lo vedo ancora davanti a me, quando ci fulminava attraverso i suoi occhiali e ci domandava con voce commossa: “Venite anche voi, nevvero, camerati?”.
Codesti educatori tengono spesso il loro sentimento nel taschino del panciotto, pronti a distribuirne un po’ ora per ora. Ma allora noi non ci si dava pensiero di certe cose.
[…] ma nessuno poté tirarsi fuori; a quell’epoca persino i genitori avevano la parola “vigliacco” a portata di mano. Gli è che la gente non aveva la più lontana idea di ciò che stava per accadere. In fondo i soli veramente ragionevoli erano i poveri, i semplici, che stimarono subito la guerra una disgrazia, mentre i benestanti non si tenevano dalla gioia, quantunque proprio essi avrebbero potuto rendersi conto delle conseguenze.
[…] Essi dovevano essere per noi diciottenni introduttori e guide all’età virile, condurci al mondo del lavoro, al dovere, alla cultura e al progresso; insomma all’avvenire. Noi li prendevamo in giro e talvolta facevamo loro dei piccoli scherzi, ma in fondo credevamo a ciò che ci dicevano. Al concetto dell’autorità di cui erano rivestiti, si univa nelle nostre menti un’idea di maggior prudenza, di più umano sapere. Ma il primo morto che vedemmo mandò in frantumi questa convinzione. Dovemmo riconoscere che la nostra età era più onesta della loro; essi ci sorpassavano soltanto nelle frasi e nell’astuzia. Il primo fuoco tambureggiante ci rivelò il nostro errore, e dietro ad esso crollò la concezione del mondo che ci avevano insegnata.
Mentre essi continuavano a scrivere e a parlare, noi vedevamo gli ospedali e i moribondi; mentre essi esaltavano la grandezza del servire lo Stato, noi sapevamo già che il terrore della morte è più forte. Non per ciò diventammo ribelli, disertori, vigliacchi – espressioni tutte ch’essi maneggiavano con tanta facilità; – noi amavamo la patria quanto loro, e ad ogni attacco avanzavamo con coraggio; ma ormai sapevamo distinguere, avevamo ad un tratto imparato a guardare le cose in faccia. E vedevamo che del loro mondo non sopravviveva più nulla. Improvvisamente, spaventevolmente, ci sentimmo soli, e da soli dovevamo sbrigarcela.
Già, la pensano così; così la pensano i centomila Kantorek! Gioventù di ferro. Gioventù!»Erich Maria Remarque
“Niente di nuovo sul fronte occidentale”
Mondadori, 1931
![]() Sarà bene che qualcuno metta in mano di tanto in tanto un libro vero a questi sedicenti storici, intrattenitori da salotto, con pretese da intellettuali, dall’alto delle loro posizioni di rendita, mentre magari si dondolano sdraiati sulla loro amaca, dispensando pensierini minimi con indignazione a buon mercato, pagata un tanto al chilo, utile per riempire il palinsesto delle loro televendite.
Sarà bene che qualcuno metta in mano di tanto in tanto un libro vero a questi sedicenti storici, intrattenitori da salotto, con pretese da intellettuali, dall’alto delle loro posizioni di rendita, mentre magari si dondolano sdraiati sulla loro amaca, dispensando pensierini minimi con indignazione a buon mercato, pagata un tanto al chilo, utile per riempire il palinsesto delle loro televendite.
![]() Potevano rileggere Pindaro, o magari il vecchio Erasmo, che dell’argomento se ne intendeva, per grattarsi via certe fregole di guerra e farsi passare il prurito.
Potevano rileggere Pindaro, o magari il vecchio Erasmo, che dell’argomento se ne intendeva, per grattarsi via certe fregole di guerra e farsi passare il prurito.
«E per non dire delle conseguenze che si producono anche dopo le guerre vittoriose e giuste: il popolo ridotto alla fame, gli aristocratici gravati di spese, tanti uomini anziani privati dei figli e, oltre alla perdita di questi ultimi, costretti a morire nell’infelicità, come se il nemico avesse portato con sé, insieme con la vita, anche la percezione del male; e, ancora, tante vecchie: spogliate di ogni bene e destinate a morire più crudelmente che se fossero state abbattute con la spada, tante vedove, tanti figli rimasti orfani, tante case in lutto, tanti ricchi ridotti in miseria. E perché dilungarsi sulle conseguenze nei costumi della gente, dal momento che tutti sanno che ogni sciagura della vita umana deriva dalla guerra? Spietatezza, disprezzo per le leggi, animi pronti a osare qualunque crimine! Dalla fonte della guerra scaturisce un’immensa caterva di ladri, rapinatori, sacrileghi, assassini. E, ciò che è ancor peggio, questa esiziale pestilenza non è in grado di restare entro i propri confini, bensì abbandona presto l’angolo del mondo in cui è venuta alla luce e non invade solo, come un contagio, le regioni confinanti, bensì trascina nel vortice comune e nella tempesta anche quelle lontane, a causa della milizia mercenaria o con il pretesto di un rapporto di parentela o di un’alleanza. E così dalla guerra nasce la guerra: da quella finta si genera la guerra vera, da un piccolo conflitto se ne produce uno immenso.»
Erasmo da Rotterdam
“La guerra piace a chi non la conosce”
Sellerio Editore, 2015
![]() E invece no, noi abbiamo Antonio Scurati (e tutta l’armata Brancaleone di sturmtruppen da salotto), che si chiede dove siano finiti i “guerrieri d’Europa” (sic!).
E invece no, noi abbiamo Antonio Scurati (e tutta l’armata Brancaleone di sturmtruppen da salotto), che si chiede dove siano finiti i “guerrieri d’Europa” (sic!).
«Chi combatterà le nostre prossime guerre? Anzi, meglio: chi combatterà al nostro posto le nostre prossime guerre? L’interrogativo aleggiava su di noi da molto tempo – ignorato, respinto, rimosso – ma è diventato assillante dopo il tradimento di Donald Trump. Perché su questo punto non debbono esserci dubbi: il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America è un traditore degli amici, degli alleati e, soprattutto, dei valori secolari della sua nazione.»
![]() Sui valori secolari della nazione americana ci sarebbe molto da dire e si potrebbe aprire un mondo… ma Scurati è fermo alla visione infantile dei cowboys buoni, contro gli indiani cattivi, coi marines che sbarcano ad Auschwitz, come ci insegnano i film di Benigni.
Sui valori secolari della nazione americana ci sarebbe molto da dire e si potrebbe aprire un mondo… ma Scurati è fermo alla visione infantile dei cowboys buoni, contro gli indiani cattivi, coi marines che sbarcano ad Auschwitz, come ci insegnano i film di Benigni.
Ma comunque…
«Si discute oramai quotidianamente della necessità di una “difesa comune europea”, di aumentare gli investimenti in spese militari, perfino della possibilità che vengano schierati nostri soldati lungo il confine insanguinato tra Russia e Ucraina. Si dibattono i problemi che ostacolano il raggiungimento di un’autonomia, se non di una impossibile indipendenza, nella difesa militare dell’Europa da eventuali, future aggressioni, purtroppo sempre più verosimili (e già in atto). Gli ostacoli sono tanti, enormi e diversi: sono di natura militare-industriale, economica, tecnologica, di natura strategica, sono, soprattutto, di natura politica.
Questo dibattito, pur necessario, si ostina però a ignorare la principale carenza europea rispetto alla possibilità di combattere autonomamente una guerra difensiva: la mancanza di guerrieri. Come, purtroppo, le recenti carneficine ucraine (e mediorientali) hanno tragicamente dimostrato, anche le guerre tecnologicamente più evolute necessitano di guerrieri. E noi europei d’Occidente non li abbiamo, non lo siamo, non lo siamo più.»
![]() Ecco cosa ci tocca leggere sulle pagine culturali, di quell’osceno foglio padronale ad uso igienico che fu un tempo La Repubblica. Una roba come questa, in altre epoche, sarebbe stata destinata a riempire le pagine satiriche di qualche giornalino umoristico ad intrattenimento salottiero; oggi è elevata a specchio dei tempi. E costituisce l’indice della levatura morale di un cetomediume riflessivo che si crede intellettuale, in un incrocio funesto tra D’Annunzio e Papini, mentre non riesci a capire se stai leggendo una parafrasi di Achille Starace o Benito Mussolini. L’effetto è straniante, ancor più che esilarante. Resta il dubbio se si stia vivendo la farsa o la tragedia. Più probabile la farsa!
Ecco cosa ci tocca leggere sulle pagine culturali, di quell’osceno foglio padronale ad uso igienico che fu un tempo La Repubblica. Una roba come questa, in altre epoche, sarebbe stata destinata a riempire le pagine satiriche di qualche giornalino umoristico ad intrattenimento salottiero; oggi è elevata a specchio dei tempi. E costituisce l’indice della levatura morale di un cetomediume riflessivo che si crede intellettuale, in un incrocio funesto tra D’Annunzio e Papini, mentre non riesci a capire se stai leggendo una parafrasi di Achille Starace o Benito Mussolini. L’effetto è straniante, ancor più che esilarante. Resta il dubbio se si stia vivendo la farsa o la tragedia. Più probabile la farsa!
![]() Lui è già entrato in guerra, al fianco degli ukronazi; eccone dunque un altro che è fermo alla Guerra di Crimea, o sogna una nuova campagna di Russia (l’ultima non è andata proprio benissimo), a patto beninteso che ad arruolarsi e partire siano gli altri, certo non il nostro fulgido samurai.
Lui è già entrato in guerra, al fianco degli ukronazi; eccone dunque un altro che è fermo alla Guerra di Crimea, o sogna una nuova campagna di Russia (l’ultima non è andata proprio benissimo), a patto beninteso che ad arruolarsi e partire siano gli altri, certo non il nostro fulgido samurai.
E chi è che ha vinto un biglietto in prima linea, per il fronte ucraino?
«Non mi riferisco qui soltanto alla penuria di soldati operativi, pur grave: la difesa del confine ucraino richiederebbe il dispiegamento di 200 mila soldati, ma la Ue sarebbe in grado di schierarne soltanto 60 mila su tre turni da 20 mila. Mi riferisco alla svanita combattività di popoli da otto decenni pacificati, demograficamente invecchiati e profondamente gentrificati. Per fare la guerra, anche soltanto una guerra difensiva, c’è bisogno di armi adeguate ma resta, ostinato, intrattabile, terribile, anche il bisogno di giovani uomini (e di donne, se volete) capaci, pronti e disposti a usarle. Vale a dire di uomini risoluti a uccidere e a morire.»
![]() Ma aspettate a trasalire, dinanzi al contenibile elàn guerriero del romanziere reclutatore, all’estasi di questo kamikaze da playstation intrappolato in un mod di Call of Duty, perché adesso viene il bello…
Ma aspettate a trasalire, dinanzi al contenibile elàn guerriero del romanziere reclutatore, all’estasi di questo kamikaze da playstation intrappolato in un mod di Call of Duty, perché adesso viene il bello…
Tenetevi forte ed allacciate le cinture!
«Che fine hanno fatto tutti quei soldati? Se lo chiedeva James Sheehan in un libro nel quale indagava la trasformazione dell’Europa da devastato campo di battaglia in società prospera e pacifica che ha dirottato tutte le sue risorse materiali e morali dal warfare al welfare. La formulazione più esatta della domanda suonerebbe, però, così: che fine hanno fatto tutti quei guerrieri?
Nella nostra millenaria vicenda, la guerra non è stata, infatti, soltanto un mestiere, una tragica costante, uno strumento di potere, è stata l’arte (il complesso di tecniche, metodi, invenzioni e talenti) che ha mosso la storia d’Europa e, all’unisono, la narrativa che ha definito l’identità degli europei. Nei secoli questa nostra terra è stato uno scoglio euroasiatico popolato di guerrieri feroci, formidabili, orgogliosi e vittoriosi. Di tutte le invenzioni europee che hanno plasmato il mondo moderno, quelle in campo bellico – tecnologiche, tattiche e culturali – sono state probabilmente le più efficaci e influenti.
Ma la guerra dei nostri antenati europei non è stata solo il dominio della forza, è stato anche il luogo di genesi del sé: da Maratona al Piave gli europei hanno combattuto (e vissuto) fedeli a come si aspettavano che la loro battaglia (e vita) sarebbe stata narrata. Da Omero a Ernst Jünger la nostra civiltà ha pensato il combattimento armato frontale, micidiale e decisivo addirittura come proprio fondamento perché nella guerra eroica ha trovato l’esperienza plenaria, l’accadimento fatidico, il momento della verità nel quale si sono generate le forme della politica, i valori della società, si sono decisi i destini individuali e collettivi.»
![]() Che detto da un abborracciato 55enne che non sopravvivrebbe una notte all’addiaccio in un bosco è davvero tutta da ridere. E nessuno che lo mandi a fare in culo!
Che detto da un abborracciato 55enne che non sopravvivrebbe una notte all’addiaccio in un bosco è davvero tutta da ridere. E nessuno che lo mandi a fare in culo!
«In Ucraina il numero di morti e feriti equivale agli abitanti di Milano. Per noi è inimmaginabile.
Riuscite a immaginarlo?»
![]() Sì, Gaza! Ma di quella, a Scurati ed agli indignati di professione come lui non è mai fregato un cazzo!
Sì, Gaza! Ma di quella, a Scurati ed agli indignati di professione come lui non è mai fregato un cazzo!
«Per i nostri antenati non è stato solo dominio militare, ma genesi del senso.
L’apocalisse in due tempi delle guerre mondiali ha estirpato questa tradizione millenaria. La rottura con essa è stata a sua volta radicale e violenta. Già con l’annichilente esperienza delle trincee nella Grande Guerra, per la prima volta in millenni di storia, i concetti di gloria, onore, coraggio persero ogni significato quando l’uomo europeo giunse alla conclusione che non c’era niente al mondo per cui valesse la pena di morire.»
![]() Qualunque cosa sia la “genesi di senso”, ne lasciamo volentieri l’interpretazione al pensoso guerriero interiore de noantri. Dubito seriamente che qualcuno sano di mente possa davvero credere che valga la pena di immolarsi per le sfilate di uno Zelensky in uniforme. Poi certo l’Esimio è liberissimo di partire ed andare a morire ammazzato dove più gli pare. Ma da solo!
Qualunque cosa sia la “genesi di senso”, ne lasciamo volentieri l’interpretazione al pensoso guerriero interiore de noantri. Dubito seriamente che qualcuno sano di mente possa davvero credere che valga la pena di immolarsi per le sfilate di uno Zelensky in uniforme. Poi certo l’Esimio è liberissimo di partire ed andare a morire ammazzato dove più gli pare. Ma da solo!
![]() In un afflato umano, riconosce pure che dopo le carneficine del secolo scorso la pace qualcosa di buono anche lo porta. Poi, per carità! Si riprende subito, fino alla chiosa terminale…
In un afflato umano, riconosce pure che dopo le carneficine del secolo scorso la pace qualcosa di buono anche lo porta. Poi, per carità! Si riprende subito, fino alla chiosa terminale…
«Resta il fatto che non siamo più dei guerrieri. Il pacifismo è stata una rivoluzione culturale, e va meditato, rispettato ma non potrà mai diventare una piattaforma politica. Per tutti questi motivi, l’imminente ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, acquisito una volta e per tutte il ripudio di ogni guerra aggressiva, nazionalista, imperialista, dovrebbe essere un passaggio cruciale affinché l’Europa ritrovi lo spirito combattivo e, con esso, il senso della lotta.
Fummo allora, noi europei d’Occidente, per l’ultima volta guerrieri. La Resistenza antifascista ci ricorda perché ripudiammo la guerra ma ci insegna anche le ragioni per prepararci, se necessario, a combatterla.»
![]() Ora, cosa c’entri la Resistenza antifascista con una simile esibizione di guerresca cialtroneria, lo sa solo la psiche distorta di questa macchietta para-mussoliniana, mentre bestemmia il nome della Liberazione con le sue intemerate (molto fasciste) ad usum belli. Tale è lo stato dell’arte, in piena distopia orwelliana.
Ora, cosa c’entri la Resistenza antifascista con una simile esibizione di guerresca cialtroneria, lo sa solo la psiche distorta di questa macchietta para-mussoliniana, mentre bestemmia il nome della Liberazione con le sue intemerate (molto fasciste) ad usum belli. Tale è lo stato dell’arte, in piena distopia orwelliana.
![]() Vi lascio con qualcosa di meglio su cui meditare, dopo cotanto pattume istituzionalizzato…
Vi lascio con qualcosa di meglio su cui meditare, dopo cotanto pattume istituzionalizzato…
“AMIAMO LA GUERRA”
di Andrea Zhok
(05/04/2025)
«Nel primo volume dei “Quaderni dal carcere” Gramsci dedica un’ampia e giustamente celebre analisi alla natura del ceto intellettuale e della loro funzione. Egli scrive:
“Gli intellettuali hanno la funzione di organizzare l’egemonia sociale di un gruppo e il suo dominio statale, cioè il consenso dato dal prestigio della funzione nel mondo produttivo e l’apparato di coercizione […] per quei momenti di crisi di comando e di direzione in cui il consenso spontaneo subisce una crisi.”
Se uno studente volesse cercare un esempio preclaro di questa funzione degli intellettuali nell’Italia contemporanea non potrebbe trovare esempio migliore dell’articolo a firma Antonio Scurati, comparso oggi sulle pagine di Repubblica, dal titolo: “Dove sono oramai i guerrieri d’Europa?” (con la parola “guerrieri” sottolineata in corsivo).
Il testo è ammirevole, perché il compito assegnato dai committenti era indubbiamente di straordinaria complessità.
La situazione cui l’intellettuale è chiamato a porre mano è critica.
Per ragioni inconfessabili, la catena di comando europea oggi desidera far passare un drenaggio di risorse pubbliche “monstre” nel nome della sicurezza e del riarmo.
Per quanto ottenebrati da reality show, talk show e sostanze psicotrope – in ordine decrescente di nocività – i cittadini europei paiono manifestare alcuni sensi di inquietudine al profilarsi di questo colossale cetriolo in volo radente. Come le mucche avviate al macello, un indefinito sospetto comincia a provocare qualche muggito di sconforto; dopo tutto, quando gli viene spiegato che per la Tac le risorse non ci sono, che per le pensioni la coperta è corta, ma che per le bombe a grappolo l’inventiva finanziaria non conosce limiti, anche i meno brillanti iniziano a sospettare che li si stia prendendo per il culo.
È questa la difficile circostanza in cui si ricorre ai superpoteri degli intellettuali a disposizione.
La commessa è di rendere attraente, fascinoso, nonché ragionevole il mostruoso aumento di spesa pubblica a finalità militari. E bisogna farlo per un elettorato che da qualche parte della mente cova ancora l’idea di essere “socialmente orientato”, talvolta addirittura “di sinistra” (o “medio-progressista” come si definiva illo tempore il Duca Conte Balabam…). E, non solo, bisogna anche spiegare perché l’unica cosa di cui si menava vanto fino a ieri come “valore fondante del sogno europeo”, cioè l’orizzonte della pace europea, ora deve trasformarsi in corsa agli armamenti e preparazione di una guerra prossima ventura.
Il compito è difficile, ma il nostro Antonio lo avremo mica fatto studiare per niente? Ed, invero, il risultato è rimarchevole, a tratti strabiliante.
Il testo parte con un attacco violentissimo nei confronti di Donald Trump, definito “un traditore degli amici, degli alleati e, soprattutto, dei valori secolari della sua nazione.” Nella chiusa del testo troveremo un’iniezione di richiamo di questo oggetto polemico con “la spregevole brutalità esibita in queste ore in mondovisione dal Presidente degli Stati Uniti d’America”.
Tra questi due estremi si sviluppa il discorso, che parte evocando con maestria l’inevitabilità della prospettiva di uno scontro bellico: “difesa militare dell’Europa da eventuali, future aggressioni, purtroppo sempre più verosimili (e già in atto).” Si noti la progressione: le aggressioni militari all’Europa nell’arco di una frase passano da “eventuali”, a “future” a “sempre più verosimili” e infine a “già in atto”.
A questo punto il terreno è predisposto: l’Europa è sola perché lo scranno del Grande Alleato è momentaneamente usurpato da un traditore, e al contempo l’aggressore è alle porte. Che fare?
Qui il testo dà il meglio di sé. Si focalizza subito sul punto cruciale.
Quanto alla produzione industriale bellica, ci sono problemi, ma grazie al cielo, vi metterà provvidenzialmente mano zia Ursula (non vediamo l’ora che faccia un contratto pluriennale con la Lockheed via sms, secondo il suo inimitabile stile). Ma il vero angoscioso problema dell’Europa è “la mancanza di GUERRIERI.” Il termine che dà l’impronta a tutto l’articolo è “guerrieri”, che compare nel titolo ed è ripetuto strategicamente ben sette volte. Non fanti, non militari, non soldati, non contractors, ma “guerrieri”. Il riferimento alle “virtù guerriere” degli avi è la chiave di lettura di tutto lo scritto, che ha il suo centro nella seguente frase: “Per fare la guerra, anche soltanto una guerra difensiva, c’è bisogno di armi adeguate ma resta, ostinato, intrattabile, terribile, anche il bisogno di giovani uomini (e di donne, se volete) capaci, pronti e disposti a usarle. Vale a dire di uomini risoluti a uccidere e a morire.”
Simpatizziamo naturalmente con l’imbarazzo di Scurati nel dover decidere se scrivere inclusivamente “uominə”, e se mandare a morire al fronte le donne sia da ritenersi idea progressiva, o quanto.
Ma imbarazzi a parte, il punto di caduta è semplice: c’è bisogno di gente disposta a uccidere e morire. E qui Scurati ha perfettamente ragione nel dubitare che la temperie culturale europea sia particolarmente propensa a tale proposta.
Da qui parte l’orazione apologetica, la cui chiave di lettura sta nella contrapposizione tra “welfare” e “warfare”. “Che fine hanno fatto tutti quei soldati?” dice Scurati, gettando uno sguardo nostalgico ai bei tempi passati delle guerre mondiali, ma poi traduce subito la frase in “Che fine hanno fatto tutti quei guerrieri?” E qui la filippica si infiamma in panegirico: “Nei secoli questa nostra terra è stato uno scoglio euroasiatico popolato di guerrieri feroci, formidabili, orgogliosi e vittoriosi.” E qui si lancia al galoppo tra Maratona e il Piave, tra Omero ed Ernst Jünger, con una tesi fondamentale da proporci: “La guerra dei nostri antenati europei non è stato solo il dominio della forza, è stato anche il luogo di genesi del senso.”
Questo è il vero e proprio colpo di genio del testo.
Lo scrittore dopo aver lamentato il fatto che le presenti generazioni potrebbero essere restie a uccidere e soprattutto a morire, dopo aver constatato l’inintelligibilità per i più del classico “Dulce et decorum est pro patria mori”, spiega al lettore che è la guerra stessa ad essere “genesi di senso”.
Cioè: non è che devi vedere un senso nel morire in guerra, è che andando a morire in guerra nascerà in te il senso di ciò che fai.
Parola di Scurati.
Dopo aver presentato la batteria completa dell’elogio delle virtù guerriere, dell’appello agli avi bellicosi e invitti, e della morte in battaglia come genesi di senso (“Viva la Muerte!”, come gridavano i falangisti), poi passa alla necessaria operazione complementare, cioè screditare i molli conforti della vita civile.
Ed è qui che troviamo autentiche perle d’ingegno come l’idea che l’insensatezza della seconda guerra mondiale avrebbe causato “una riluttanza ironica, un malinconico disincanto del mondo” da cui nasce sì il progresso del dopoguerra, ma è un “avanzare regressivo verso forme di vita che estendano a ogni età le cure amorevoli riservate all’infanzia o, addirittura, i privilegi embrionali di protezione e nutrimento. Questa è la civiltà: il grande utero esterno.” Traduzione: il progresso sociale che sì, certo, ci fu, chi può negarlo, però fu un “avanzare regressivo” (premio ossimoro del secolo). In questo “avanzare regressivo” siamo stati rammolliti dall’eccesso degli agi del welfare (da cui – sempre siano lodati – hanno già pensato a sottrarci in parte Monti, Draghi, e altri medio-progressisti). Il welfare insomma è una fase di infantilizzazione, un regresso intrauterino, da cui, o gioventù europea, è ora di svegliarsi!
Se le cose andranno come auspica, Scurati sarà il nostro Giovanni Papini; quel Papini che scriveva su Lacerba nell’ottobre 1914 un articolo dal titolo “Amiamo la guerra”: “Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero dopo tanti umidicci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne.”
Mi sono soffermato forse troppo su questo testo, ma la sua natura estremamente insidiosa credo lo richiedesse. Si tratta di un testo insidioso perché mescola elementi descrittivamente reali con un’interpretazione falsa come Giuda.
Ciò che del testo è vero è che oggi ben pochi sarebbero disposti in Europa “a rischiare la vita per altri” e a “morire per la patria”. Personalmente condivido l’idea che questo fatto non sia un segno di salute spirituale. Il fatto che pochi pensino di avere una cosa, una qualunque cosa, per cui sarebbero disposti a morire non è un segno di forza ma di estrema debolezza spirituale.
Solo che la lettura che Scurati dà di questo fatto è totalmente farlocca.
Non è dalla seconda guerra mondiale che emerge una gioventù affetta da “riluttanza ironica e malinconico disincanto”, ma dal trionfo dell’organizzazione neoliberale della società, dalla metà degli anni ’70. Il “rammollimento” non è avvenuto nell’epoca del welfare, ma nell’epoca della sua distruzione progressiva.
Non è mai la guerra ad essere genesi di senso; la guerra può consolidare ed arricchire un senso, se e nella misura in cui ciò per cui si muore in guerra venga percepito come dotato di senso.
Ed oggi di morire per i valori di Soros, per le commesse della von der Leyen, per il buen retiro di Borrell nel suo giardino, non ha voglia nessuno che sia sano di mente.
La questione di fondo è semplice caro Scurati, cari lettori di Repubblica, cara von der Leyen: avete distrutto sistematicamente per decenni ogni senso di appartenenza, storica, culturale, territoriale, perché non era abbastanza moderna e globalizzata; avete smantellato ogni identificazione con sorti collettive ed ogni solidarietà, perché la competizione innanzitutto; avete coltivato pervicacemente il peggior individualismo autoreferenziale, perché questa è la libertà di mercato; avete frantumato la schiena a famiglie, comunità, lealtà personali, perché erano “conservatrici e retrive”; avete distrutto qualunque valore sostituendolo con un prezzo; ed ora dopo aver seminato nichilismo per due generazioni, vi lamentate perché non trovate manovalanza disposta a morire per la vostra ibrida e per il parcheggio in ZTL?
Questo è l’elmetto, questa la baionetta del nonno, prego, dopo di voi.»